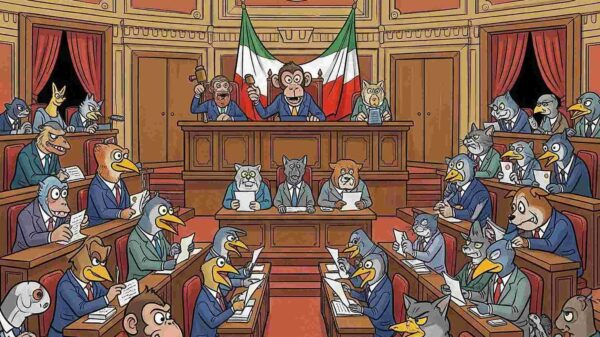Le Marche sono la prima regione ad essersi dotata di un Piano di adattamento al cambiamento climatico (Pracc). Approvato il 12 febbraio dall’assemblea legislativa, affronta le sfide poste all’agricoltura valutando come elementi di fragilità la sua vocazione alla cerealicoltura (151 mila ettari di cui quasi 100mila di frumento duro) e l’incidenza importante delle foraggere (prati e pascoli). E ciò proprio perché la poca efficienza dei sistemi irrigui non consente di fare colture orticole, frutticole, floricole più redditizie. Altra debolezza, la tendenza a praticare gli allevamenti di tipo intensivo. I rischi sono che l’agricoltura intensiva possa favorire fenomeni di degrado del suolo e, quindi, ridurre la capacità produttiva in generale e provocare perdita di biodiversità microbica del suolo e biologica a livello dell’ecosistema.
Due macro-obiettivi

Il Piano, quindi, persegue due macro-obiettivi. Il primo è supportare la resilienza con delle misure che creano strumenti per supportare le scelte colturali in previsione degli andamenti meteo incluse quelle relative all’uso irriguo dell’acqua e proteggono l’apicoltura. Il secondo è rendere l’agricoltura uno strumento di adattamento ai cambiamenti climatici al fine di prevenire l’erosione del suolo attraverso buone pratiche agricole. Le misure attivabili prevedono di incentivare sistemi di coltivazione più performanti che non ledono al suolo e modalità di gestione dei suoli che migliorano le loro capacità idrologiche ossia di assorbire e trattenere l’acqua.
I punti di forza
Misure che acquisiscono una dimensione particolare se contestualizzate attraverso l’analisi dei punti forza dell’agricoltura regionale. Per il Piano, sono identificabili nella crescita delle produzioni biologiche (occupano il 26% della Sau) e nella presenza di quattro università, di diversi centri di ricerca specializzati e del lavoro dell’agenzia Marche agricoltura e Pesca (Amap). Istituti che rappresentano una risorsa per l’innovazione del settore anche se – precisa una nota – emerge ancora una scarsa integrazione tra ricerca e aziende agricole.
Al dunque, il Piano mira ad aiutare l’agricoltore nella sua gestione in una logica di lungo periodo e a supportarlo negli impegni della politica agricola europea. Per farlo mira a creare un sistema di informazione che va, ad esempio dalla comunicazione dei volumi d’acqua necessari in relazione alle esigenze delle coltivazioni e del suolo al predisporre strumenti di previsione meteo associate ad informazioni idrologiche e biologiche dei suoli, delle piante. Bollettini frequenti anche settimanali che porterebbero a scelte di coltivazione più idonee ed efficaci.