La visciola rappresenta una delle produzioni più distintive e allo stesso tempo più fragili del patrimonio agroalimentare marchigiano. Divisa tra due aree di riferimento – il Pesarese e l’ Anconetano- questa eccellenza rischia oggi di restare confinata nella dimensione artigianale, nonostante il suo valore storico, culturale e commerciale. Di tutto questo si è discusso nel corso del convegno “La visciola delle Marche: due sponde, un’identità”, cheha riunito a San Paolo di Jesi istituzioni, tecnici, produttori e rappresentanti del mondo accademico per fare il punto sulle opportunità e le criticità legate al destino del prodotto.
Una risorsa autoctona da strutturare
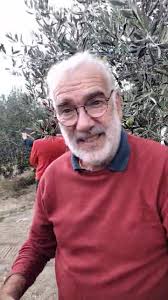
“Le Marche contano oltre 140 varietà autoctone censite,” ha ricordato Davide Neri, direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche. “Tra queste anche la visciola, una risorsa del nostro germoplasma regionale, presente soprattutto in due zone: Cantiano e la valle dell’Esino.”
Il professor Neri ha evidenziato la necessità di un lavoro strutturato e coordinato tra istituzioni, produttori e ricerca, per passare dalla produzione domestica a una filiera organizzata: “Servono impianti e materiale genetico certificato, vivaisti dedicati e tecniche colturali moderne. Oltre alla possibilità di lavorare su piante autoradicate o innestate, oggi è disponibile anche materiale in vitro, che può garantire tracciabilità e qualità. Ma occorre pensare anche alla sostenibilità: eventi climatici estremi, come siccità e temperature anomale, compromettono la produzione”
Il rischio, secondo Neri, è che la discontinuità produttiva freni la possibilità di riconoscimento ufficiale. “La visione deve essere quella di una comunità che si organizza per garantire quantità e qualità costante. Solo così il prodotto potrà uscire dal confine della produzione familiare e diventare una vera risorsa economica per il territorio.”
A condividere la stessa linea anche Angelo Serri, direttore del Tipicità Festival: “La visciola è la grande assente tra le eccellenze marchigiane, nonostante la sua unicità e la forte identità territoriale. È incredibile che un prodotto così radicato non abbia ancora una valorizzazione strutturata. Dobbiamo costruire una collaborazione concreta tra i produttori del nord e del sud della regione e dare alla visciola la dignità che merita nel nostro paniere regionale.”
Le due visciole marchigiane
Sul piano tecnico e produttivo, il confronto ha messo in evidenza le due principali interpretazioni del vino di visciola: quella della Vallesina e quella di Cantiano.
Giselle Cardinali, delle Cantine del Cardinale di Serra de’ Conti, ha raccontato il metodo tradizionale della zona anconetana: “La nostra è una lavorazione lunga e naturale. Le visciole vengono raccolte la prima settimana di giugno a mano, selezionate e lasciate fermentare al sole con lo zucchero per 40 o 50 giorni. Poi, a metà settembre, vengono aggiunte al mosto fresco e inizia la seconda fermentazione. Il vino prende così colore, profumo e carattere. Una volta terminata la fermentazione si tolgono le visciole e viene aggiunto al vino il succo tolto in precedenza. Tutto il procedimento dura circa un anno e mezzo.”
Diversa invece la tradizione del Pesarese, rappresentata da Yuri Pierelli dell’azienda Visner di Pergola: “Noi partiamo dal vino finito, non dal mosto. È una tradizione antica, legata alla ricetta pergolese originale: 5 chili di visciole, 2 chili di zucchero e 7 litri di vernaccia. Alcuni aggiungevano un po’ di alcol per garantire la conservazione”.
Due metodi diversificati in primis dalla base di partenza del prodotto, il mosto nel primo caso ed il vino nel secondo, una differenza che è all’ origine di un “Vino di Visciola” che potrebbe comunque trovare un’unica identità regionale, ma che implica alcune sostanziali problematiche non appena viene a confrontarsi con la normativa.
Norme, definizioni e percorsi di tutela
 Sul fronte normativo, la situazione è infatti tutt’altro che semplice. Ad illustrarla sono stati Ferruccio Luciani, della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche e Silvio Salvi, consulente ed ex funzionario del Ministero dell’Agricoltura.
Sul fronte normativo, la situazione è infatti tutt’altro che semplice. Ad illustrarla sono stati Ferruccio Luciani, della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche e Silvio Salvi, consulente ed ex funzionario del Ministero dell’Agricoltura.
La prima sfida è definire in modo chiaro che cos’è il vino di visciola: una bevanda aromatizzata a base di vino, o una bevanda alcolica generica? Il confine è labile e dipende dal metodo produttivo. “La visciola – ha spiegato Salvi – potrebbe rientrare nei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che secondo il regolamento europeo 251/2014 devono contenere almeno il 50% di vino o mosto in fermentazione. Tuttavia, se la base è solo mosto, allora si entra nella categoria delle bevande alcoliche generiche, che non possono utilizzare termini legati al vino. È una questione di definizione, ma fondamentale per stabilire la denominazione legale del prodotto.”
Per la normativa europea dunque una Bevanda aromatizzata a base di vino non potrebbe avere il mosto come base di partenza. Al tempo stesso, alle bevande alcoliche non è permesso l’accostamento con la terminologia appartenente al mondo vitivinicolo, decisione presa dal legislatore per tutelare il vino dalle appropriazioni indebite.
“Per questo – ha aggiunto– occorre stabilire un disciplinare che permetta di raccontarla in modo coerente e di regolamentarne la composizione. Poi serve un’associazione di produttori, rappresentativa e coesa, per poter avviare un percorso di riconoscimento.”
Una soluzione veloce e percorribile, secondo Luciani, sarebbe la creazione di un marchio collettivo regionale, che garantirebbe visibilità e tracciabilità in tempi brevi. Oppure, suggerisce Salvi, un percorso verso la Specialità Tradizionale Garantita (STG), che tutela la ricetta e il metodo produttivo, come avvenuto per alcuni prodotti come la pizza napoletana. “Il marchio europeo STG non protegge l’origine geografica,” ha spiegato, “ma obbliga i produttori a seguire la ricetta tradizionale, e potrebbero essere menzionati entrambi i metodi di lavorazione: sarebbe già un passo importante e sicuramente fonte di visibilità.”
Salvi ha anche ricordato che i Pat (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) non forniscono tutela né sull’origine né sulla provenienza, ma solo memoria storica. “Se vogliamo davvero proteggere la visciola, dobbiamo passare a strumenti europei. Marchio collettivo o STG, entrambe le strade sono valide: l’importante è partire da una filiera unita e organizzata.”









