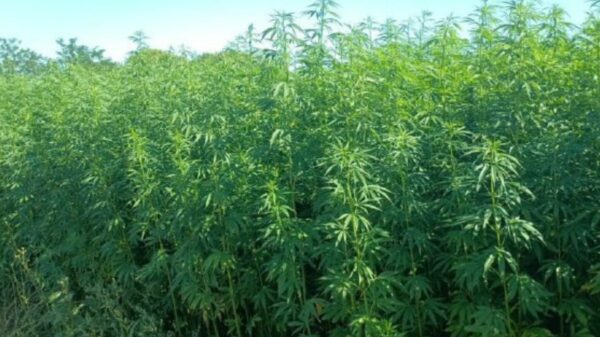A pochi chilometri da Arquata del Tronto, nel comune di Acquasanta Terme, sorge Favalanciata, una piccola frazione che porta nel nome la traccia del suo prodotto simbolo: la fava. È da questo legume che, dopo il terremoto del 2016, è ripartita una storia di riscoperta e di comunità, guidata da un gruppo di volontari riuniti nella Comunità Slow Food di Favalanciata.
Una comunità nel nome della biodiversità culturale

«Siamo una comunità Slow Food, non un presidio, come lo è ad esempio quello delle Fave di Fratte Rosa – spiega Matteo Mattei, portavoce del gruppo –. Il presidio è formato da produttori, noi invece siamo volontari che si sono riuniti per ridare valore al prodotto che dà addirittura il nome al nostro paese.» L’obiettivo non è solo quello di valorizzare una varietà locale, ma di preservare la biodiversità culturale di un territorio fragile. «La nostra è una biodiversità che porta oltre il terremoto» aggiunge Mattei.
L’idea è nata proprio nel periodo immediatamente successivo al sisma del 2017, quando il gruppo cercava un modo per mantenere viva l’attenzione su una zona colpita duramente. «Prima che si spegnessero i riflettori sul nostro territorio, volevamo trovare un motivo per far continuare a parlare di Favalanciata anche per altri aspetti. Da una chiacchierata con un commerciante del posto, molto attivo nel volontariato, è nata l’idea: perché non provare a fare una crema di fave?».
La nascita della crema di fave
 Da quell’intuizione è nato un prodotto oggi diventato il simbolo della comunità. «Abbiamo iniziato a fare delle prove e ci siamo accorti che nessuno fino ad allora produceva una crema partendo da fava fresca. I prodotti che trovavamo in commercio derivavano tutti da fava essiccata. Il nostro tentativo è riuscito e abbiamo deciso di far conoscere la crema aprendo una pagina Facebook. Da lì abbiamo organizzato un piccolo evento, e il prodotto ha avuto subito successo.»
Da quell’intuizione è nato un prodotto oggi diventato il simbolo della comunità. «Abbiamo iniziato a fare delle prove e ci siamo accorti che nessuno fino ad allora produceva una crema partendo da fava fresca. I prodotti che trovavamo in commercio derivavano tutti da fava essiccata. Il nostro tentativo è riuscito e abbiamo deciso di far conoscere la crema aprendo una pagina Facebook. Da lì abbiamo organizzato un piccolo evento, e il prodotto ha avuto subito successo.»
Le prime produzioni sono nate dalle fave degli orti familiari e dalle piccole riserve rimaste. In breve tempo sono arrivate le prime attenzioni dei media: «Nel 2018 alcuni giornalisti che stavano lavorando nel cratere hanno raccontato la nostra esperienza insieme ad altre realtà locali impegnate nella ripartenza. Poi nel 2019 una cantina della zona ha portato i nostri vasetti al Vinitaly, e un ragazzo li ha presentati a un concorso: abbiamo vinto il Premio Sfiziosità d’Italia di Agrifood.»
La crema di fave di Favalanciata contiene il 90% di fave fresche, con l’aggiunta di olio extravergine d’oliva e mentuccia. «All’inizio avevamo qualche problema tecnico – racconta Mattei -: il tappo dei vasetti tendeva ad annerirsi, perché non utilizziamo conservanti. Alcuni commercianti se ne lamentavano, così abbiamo dovuto diversificare la produzione e ci siamo rivolti a una cooperativa locale per l’approvvigionamento delle fave.»
Il legame con Slow Food e le origini della fava
 L’esperienza ha portato la comunità a entrare in contatto con Slow Food, che in quegli anni sosteneva i territori del cratere. «Abbiamo iniziato a fare ricerche su un legume che è sempre stato presente nelle case di Favalanciata. Ogni famiglia aveva quattro o cinque piante e, quando si seminava, il seme veniva preso dalla comunità agraria. Abbiamo deciso di continuare ad usare lo stesso seme, mantenendo viva la tradizione e la varietà.»
L’esperienza ha portato la comunità a entrare in contatto con Slow Food, che in quegli anni sosteneva i territori del cratere. «Abbiamo iniziato a fare ricerche su un legume che è sempre stato presente nelle case di Favalanciata. Ogni famiglia aveva quattro o cinque piante e, quando si seminava, il seme veniva preso dalla comunità agraria. Abbiamo deciso di continuare ad usare lo stesso seme, mantenendo viva la tradizione e la varietà.»
Le ricerche hanno permesso di ricostruire anche le origini del nome del paese. «Secondo la tradizione – spiega Mattei – il nome Favalanciata deriverebbe dal fatto che i muli, quando percorrevano le mulattiere carichi di prodotti, soffrivano di vertigini e a volte perdevano il carico. Nel carico c’erano anche le fave, che finivano a terra: da qui il nome.»
Le testimonianze storiche hanno confermato che la fava era già presente nell’Ottocento: «Abbiamo trovato documenti che attestano la vendita delle fave nel mercato di Acquasanta e persino un riferimento in un’opera del Crivelli, che le raffigura sotto i piedi della Madonna, a testimonianza della loro presenza nella regione.»
Coltivazione semplice
Si seminano seguendo le fasi lunari. «Le mettiamo a terra con la luna nuova – spiega Mattei – il 17 o il 27 ottobre, oppure il 7 novembre, quando il terreno è attorno ai 18 gradi. È una pianta che cresce da sola, senza bisogno di trattamenti o irrigazione.» Il ciclo di vita dura circa nove mesi, e la raccolta avviene a fine maggio, periodo in cui la comunità organizza un pranzo dedicato. «Ogni anno proponiamo un menù interamente a base di fave e sperimentiamo piatti nuovi: dal gelato alle fave alla pizza con fave, cozze e pecorino.»
La varietà locale si distingue per essere più croccante rispetto, ad esempio, a quella della Valdaso e per il sapore intenso e fresco. La produzione annuale di fava fresca si aggira sui 200-300 chili.
Dentro e fuori da Favalanciata
Il progetto di Favalanciata non si limita al recupero agricolo, ma punta anche a creare relazioni. «Siamo entrati nella rete Slow Beans e abbiamo avviato scambi di semi con il Sudafrica, l’Etiopia, l’Oregon e il Belgio – racconta Mattei -. È bello sapere che un seme del nostro territorio viaggia nel mondo e racconta chi siamo.»
Nonostante i risultati, restano alcune criticità. «Quando si parla di turismo in questa zona si citano sempre solo funghi e tartufi. Nel mondo istituzionale, sono pochi a menzionare la comunità Slow Food di Favalanciata, e questo rappresenta per noi un limite.»
«In pochi anni siamo riusciti a fare tanto – conclude Mattei – e questo ci dà comunque la spinta per continuare a valorizzare la nostra fava, migliorare la filiera e portare avanti nuovi progetti legati alla promozione del territorio». Una storia che, come i semi della sua fava, vuole continuare a germogliare anno dopo anno.